Torna con Alphabeta il romanzo di Romana Pucci L’uva barbarossa, ambientato nella Bolzano della guerra e del dopoguerra.

Rif. bibl.: Romeo, Carlo, Sogni persi nella città in guerra, in «Alto Adige», 2 aprile 2021, pp. 10-11.
Romana Pucci, L’uva barbarossa,
con postfazione di Carlo Romeo
Edizioni Alphabeta Verlag, Merano 2021
ISBN 978-8872233719
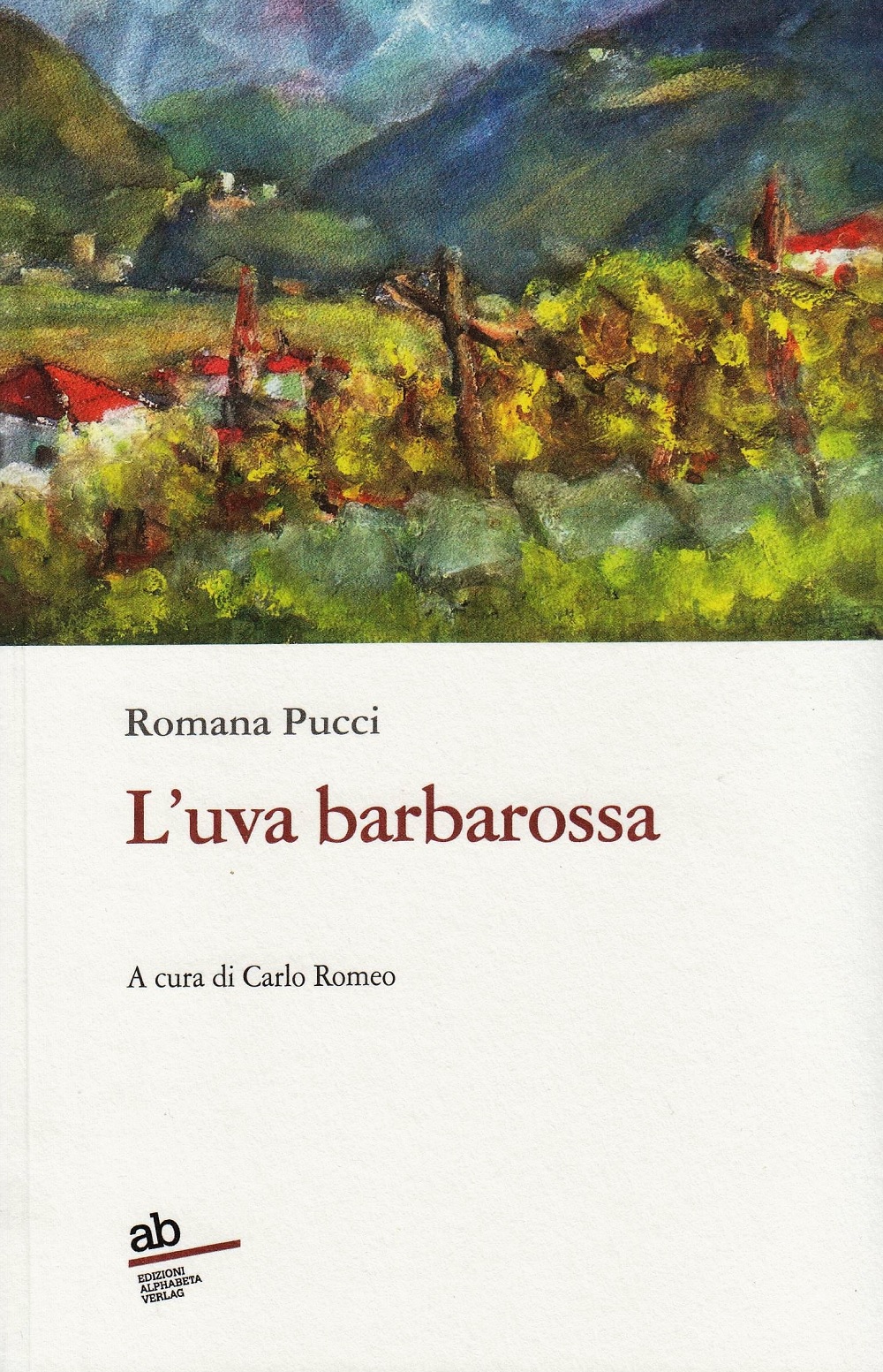
Disincanti della memoria
L’uva barbarossa di Romana Pucci
di Carlo Romeo
«Fatte a piedi due strade, gravati di bagagli, ci infodera un ghetto FFSS, ce n’è dovunque; e ghetti INCIS, ghetti semirurali per anomala ZONA INDUSTRIALE. Una cerchia sconnotata, senza storia, né tradizioni, né linguaggio in comune e, in mezzo, rocca asburgica di cittadini asburgici ottativi italiani (per la terra, che è lo zoccolo della patria)».
Così Romana Pucci dipinge il suo arrivo a Bolzano, nell’ottobre 1940, attraverso le insegne di una città-cantiere babelica, frammentata nei diversi dialetti e “ghetti” abitativi e sociali. E accanto il mondo tedesco, arroccato e impenetrabile come i suoi aspri fonemi. Spigolose e intense, tenere o caustiche, basterebbero poche pagine del romanzo L’uva barbarossa per fissarne un posto di rilievo nella rappresentazione letteraria del vissuto di migliaia di famiglie immigrate in Alto Adige tra le due guerre. Uscito nel 1983 per Rusconi, il romanzo viene ora riedito dalla meranese Alphabeta nella collana «Reprint», dedicata ai classici dimenticati della letteratura altoatesina.
Romana Pucci (1928-1990), originaria del Pistoiese, arrivò con la famiglia a Bolzano al seguito del padre ferroviere. Vi rimase sino alla fine degli anni Cinquanta, quando si trasferì a Milano col marito Anselmo Bruni, per molto tempo docente di storia e filosofia al Carducci. Coltivò inizialmente la poesia, pubblicando due raccolte e segnalandosi in concorsi nazionali. Giunse alla prosa abbastanza tardi, ma il suo romanzo d’esordio - La volanda (Einaudi 1979), ispirato alla sua infanzia toscana - rappresentò un piccolo caso letterario: «luminoso racconto» lo definì Natalia Ginzburg, «piccolo capolavoro» Lalla Romano, «progetto letterario di grande respiro» Sebastiano Vassalli, insieme a Carlo Sgorlon, Giovanni Raboni e altri. Colpivano la profondità del recupero memoriale e l’originalità della scrittura, la contaminazione tra registri letterari, colloquiali e dialettali, un repertorio lessicale così fuori dall’ordinario da affascinare persino un severo filologo come Roberto Ridolfi.
L’uva barbarossa rappresentava la continuazione autobiografica del primo romanzo e raccontava il vissuto della scrittrice dalla fine degli anni Trenta all’immediato dopoguerra, periodo trascorso a Verona e poi a Bolzano: «un tempo misterioso, dieci volte più grande del reale; si cresce per anni con lentezza e, con lentezza atroce, ho vissuto la guerra». Se nel primo romanzo i ricordi dell’infanzia toscana sembravano trasfigurarsi in allegorie senza tempo, come le favole, qui le esperienze irrompono, dissonanti e persino brutali, attraverso la percezione della più irrequieta delle età umane, l’adolescenza. La scrittrice cerca di restituirne gli echi con la massima fedeltà, col massimo grado di regressione possibile, producendo a volte un effetto quasi diaristico. Il vissuto coincide con un periodo quanto mai denso di avvenimenti di forte polarizzazione e impatto emotivo: la guerra, la caduta del fascismo, l’occupazione nazista, i bombardamenti. Agli occhi di un’adolescente il mondo “impazzito” degli adulti non può offrire certezze, con i miti che crollano di colpo come le case buttate giù dalle bombe, e nessuna frase imparata a scuola sembra reggere alle prove della vita e della storia.
Tutto il libro, fin dalla dedica, può essere interpretato come il ritratto psicologico del padre che prende forma nei frequenti dialoghi con la figlia. Infaticabile lavoratore, pronto a qualunque sacrificio per la famiglia, ha una vena di arguzia popolare tutta toscana, sciorinata in proverbi, battute e citazioni di Dante e del Giusti. Il suo «bastone da maresciallo», cioè la sua massima ambizione, è quanto mai semplice e riporta ad avite radici contadine: poter disporre, dopo la pensione, di un pezzetto di terra da coltivare e sulla tomba il più umile dei vitigni, l’uva barbarossa.
Lontano da militanze politiche, sentimentalmente anarchico, non ha in simpatia il regime ma continua a confidare in Mussolini, «forse figura mitica, paterna, per ragazzo cresciuto senza padre. Digiuno di politica, guarda la nave, non la scia che produce». Dalla cabina della sua locomotiva, assiste sbigottito ai tragici rivolgimenti, reagendo nell’unico modo per lui possibile, con gesti di istintiva solidarietà.
Il suo disorientamento è lo stesso della figlia e raggiunge il culmine il mattino del tre maggio 1945. Nelle confuse sparatorie che a Bolzano si verificano tra reparti germanici in ritirata verso nord e formazioni partigiane, il padre rimane gravemente ferito a un braccio mentre, al piano sottostante dell’appartamento dei Pucci, viene colpito a morte un ragazzo (Giorgio Sarri). Spesso i risvolti con cui i grandi eventi coinvolgono (e stravolgono) le piccole vite sembrano grotteschi: nel giro di pochi giorni al padre giunge la comunicazione della concessione del cosiddetto “brevetto Alexander” (come “patriota ferito”) e quella di un procedimento di epurazione, con temporanea sospensione dal servizio. Tutto ciò lascerà un segno profondo nell’accesa sensibilità della figlia. L’amarezza di quelle esperienze si proietta anche sulla narrazione delle successive vicende (la povertà del dopoguerra, i successi scolastici accompagnati però da solitudine e incomprensione nel rapporto con gli altri), come se un improvviso disvelamento avesse spazzato via per sempre ogni illusione «a coloro per i quali la guerra non è finita nel 1945».