
Recensione di Autismi di Giacomo Sartori, uscito quest’anno per Miraggi edizioni (di Roberto Antolini).
LÀ DOVE LE IDEE SBATTONO CONTRO LE PARETI DI ROCCIA
L’ULTIMO LIBRO DI GIACOMO SARTORI “AUTISMI”
di Roberto Antolini
I racconti di Autismi, sono stati dati in pasto al pubblico, la prima volta, sull’importante pagina WEB di letteratura «Nazione Indiana» (www.nazioneindiana.com) tra il dicembre 2008 e il gennaio 2010. La prima edizione cartacea, del 2010 (Broni PV, Sottovoce), è stata praticamente underground: 113 copie, di cui 35 inviate – come da bando – al Premio Settembrini 2011, al quale premio il libro è entrato nella cinquina finale. Il racconto I pesci pescati ha vinto, sempre nel 2011, in Premio Frontiere/Grenzen. Dal racconto La mia città è stato tratto, dall’autore stesso, il monologo Dispatrio arrivato secondo al concorso Per voce sola, ed è stato pubblicato nella raccolta Per voce sola 2013. Antologia del Concorso nazionale per autori di monologhi (Cuneo, Nerosubianco, 2013). Tre racconti sono stati pubblicati sulla «Massachusett Review» nel 2015, e quattro sulla parigina «Revue Littéraire» nel 2017.
Da questa rassegna delle fortune/sfortune editoriali del libro e dei racconti contenuti (Sartori dice che hanno avuto: «una loro vita ostica ma anche bella») risalta già il contorno della figura dell’autore: universalmente considerato uno dei migliori narratori italiani, ma al quale gli editori non spalancano le braccia, e così lui deve cambiarli ad ogni nuovo libro. Gli editori evidentemente diffidano un po’ di questo autore trentino-parigino un po’ “strano”: fecondo autore di storie, che però non rientrano quasi mai nei canoni commercial-standard dell’editoria attuale, inseguendo vene irregolari, e mettendo in scena personaggi dagli equilibri psichiatrici non sempre a piombo, in una scrittura che ha qualcosa di allucinato.
A queste caratteristiche non sfugge Autismi, che finalmente, nell’aprile 2018, è uscito in una edizione da grande distribuzione (Torino, Miraggi edizioni), tranquillamente reperibile in libreria. Non avrei dubbi ad affermare che Autismi è il vero capolavoro di Sartori, il libro nel quale le caratteristiche del suo lavoro letterario vengono meglio valorizzate ed amalgamate, producendo un testo dalla efficacia esemplare, grondante di graffiante scherno sociale, ma al contempo ricco di una vena intima di melanconica (anche se ironica) pietas per la condizione umana.
Il testo è basato su una scrittura controllatissima, capace di costruire scenari minuziosamente dettagliati, per poi sbriciolarli con una battura irridente, al vetriolo. E forse alla natura guizzante di questa scrittura non è indifferente l’essere nata per la rete, spazio dove la comunicazione si fa appunto obbligatoriamente d’effetto, rapida e scoppiettante (pena il perdersi subito il lettore per via). Sartori mette qui in scena la “commedia umana”, ma a partire da sé, con uno sguardo che solo poi si allarga - altrettanto ironico - agli altri, agli spettatori. Mette in scena un anti-eroe postnovecentesco, perché pur sempre parente dell’anti-eroe autoironico alla Svevo, ma qui con una vena apocalittica e surreale che agli anti-eroi borghesi mancava. La “commedia umana” è qui passata in rassegna a partire dal personaggio dell’io narrante (molto simile per certe caratteristiche biografiche all’A.), scomposta in singoli racconti per ogni snodo del personaggio.
Il primo è giustamente quello che caratterizza ogni posizione sociale: il Lavoro (quello che nobilita l’Uomo!). E Sartori si dilunga da p. 9 a p. 18 a descrivere Il mio lavoro. Apprendiamo così che «Il mio lavoro consiste nel far buche nella terra. Buche grandi e profonde, in cui ci entra comodamente una persona. Poi appunto ci entro dentro. Mi ci seppellisco, si potrebbe dire. Però a differenza di un vero seppellimento nessuno poi aggiunge altra terra tra me e lo scavo. Contrariamente a un vero funerale posso muovere le braccia, posso respirare come voglio, posso venir fuori quando ho finito».
In seguito il racconto si dilunga su una molteplicità di particolari: su dove fa le sue buche, sul fatto che per queste lo pagano, non tanto ma insomma ci vive, che la sua è una attività molto solitaria, che nel suo lavoro ci si sporca molto ecc. Lamenta che i suoi «conoscenti stentano a capire che lavoro faccio», ma per il lettore è la stessa cosa: è assolutamente impossibile capire quale sia il lavoro, il settore produttivo, lo status sociale dell’io narrante. La condizione professional-sociale viene quindi in questo modo assolutamente irrisa con un ondeggiare sussiegoso di chiacchiere da salotto - o da bar, per non citare Salvini! - a cui manca solamente l’essenziale. La condizione sociale, base di ogni gerarchia sociale, affonda in una melassa.
Questo è lo stile, che devo dire non manca di un plot: quello che tiene il lettore incollato alla pagina. Solo che rimane ignoto: c’è, si sviluppa, ma improvvisamente si perde per strada.
Dal lavoro si passa a Il mio primo infarto, dove si descrive l’esplodere del dolore paralizzante, le mille avventure per arrivare al Pronto Soccorso, dove lo fanno passare davanti a tutti, bollino rosso: «era chiaro che il caso più urgente ero io». Cosa che lo precipita nel panico. Fino a quando non arrivano i primi dati. «Non si trattava affatto di un infarto, mi dissero prima ancora che fosse finito l’elettrocardiogramma: il tracciato non rivelava niente di anormale. E comunque in nessun caso l’infarto dava i dolori che avevo descritto. Senza contare che il cuore era molto più in basso di dove indicavo io».
E via di questo passo, da Il mio attuale editore ̶ quello che «quando gli telefono per qualche istante sta zitto. Poi parlando molto forte dice che non sente. PRONTO!, PRONTO!, NON SENTO!, grida, come appunto uno che sente malissimo. Poi mette giù. Quando richiamo il telefono è occupato, o c’è la segreteria» ̶ alla sorella, al suocero, alla cacca «troppo fluida, a volte spugnosa, se non addirittura acquosa», al migliore amico, morto – dove mescolata all’abituale ironia è avvinta inscindibilmente una melanconia struggente per il tempo che passa e ci porta tutti via – all’abitudine giovanile per la pesca, ora abbandonata, perché adesso «non potrei pensare che un essere vivente ha un amo piantato nella bocca, e che quell’amo glielo ho piantato io. Non potrei sopportare quel dolore che perdura, che con i movimenti inconsulti si aggrava. Non potrei più astrarmi da quella rabbiosa sofferenza. Ma all’epoca non mi facevo questi problemi» (le associazioni di pescatori prendano e portino a casa).
Naturalmente non possono mancare – per parallelismo con lo Zeno Cosini – le sedute di psicoterapia, in coppia con la moglie, dove i due cercano di copiarsi i disegni che la psicanalista prescrive, e ridono dei suoi tic; alla fine si ritrovano, senza capire come mai, fuori dalla crisi, a copulare beatamente, come la stessa aveva consigliato di fare.
Ma la cosa che dà il tono al libro, e produce sul lettore di qualunque paese un impatto emotivo (anche se difficile da definire, nelle sue componenti) è il testo La mia città, dedicato alla pur innominata Trento, che non ha mancato di provocare anche qualche prurito istituzionale:
«La mia città è una città grigia infossata in una valle grigia costeggiata da minacciose montagne grigie. Il cielo è grigio, il fiume che si trascina stancamente è grigio, e anche gli stentati alberi sono grigi, con appena qualche moribondo riflesso verde marcio. Il dilagante cemento è paradigmaticamente grigio, così come i ridondanti asfaltamenti e le fumosità imprigionate dalla nefasta conformazione orografica. Perfino i laghi sono stagnanti e grigi. Nulla da stupirsi che anche gli abitanti siano grigi. Il sole poveretto è costretto a tramontare altissimo nel cielo, un disgraziato che viene impiccato in cima a un funambolico patibolo. Ogni sera è lo stesso affliggente spettacolo. Per fortuna molto spesso piove, e quindi l’esecuzione si svolge dietro una cortina grigia di nuvole».
Le cime alpine, che nella pubblicità incoronano felicemente la “capitale della montagna”, non ne escono bene. «Il problema naturalmente sono le montagne, che impediscono allo sguardo di spaziare e di muoversi a piacimento, di ritemprarsi, di riposarsi. Per non parlare delle idee, che appena nate sbattono contro le pareti di roccia, e muoiono tra atroci dolori».
Sono parole così aguzze che mi ricordano un altro grande iconoclasta nei confronti del luogo natio: il sudtirolese N.C. Kaser. Ma come per Kaser, anche per Giacomo Sartori – come per tutti ̶ il rapporto è tutt’altro che risolto.
«Riesco finalmente a respirare, quando ho acquistato il biglietto di sola andata, quando ne sento la pressione lieve ma anche inflessibile nella mia tasca. La visione delle montagne mi diventa sopportabile. Mi dico che le vedo per l’ultima volta, e ne provo quasi un malinconico struggimento».
Giacomo Sartori, Autismi, Torino, Miraggi edizioni, 2018, € 16,00
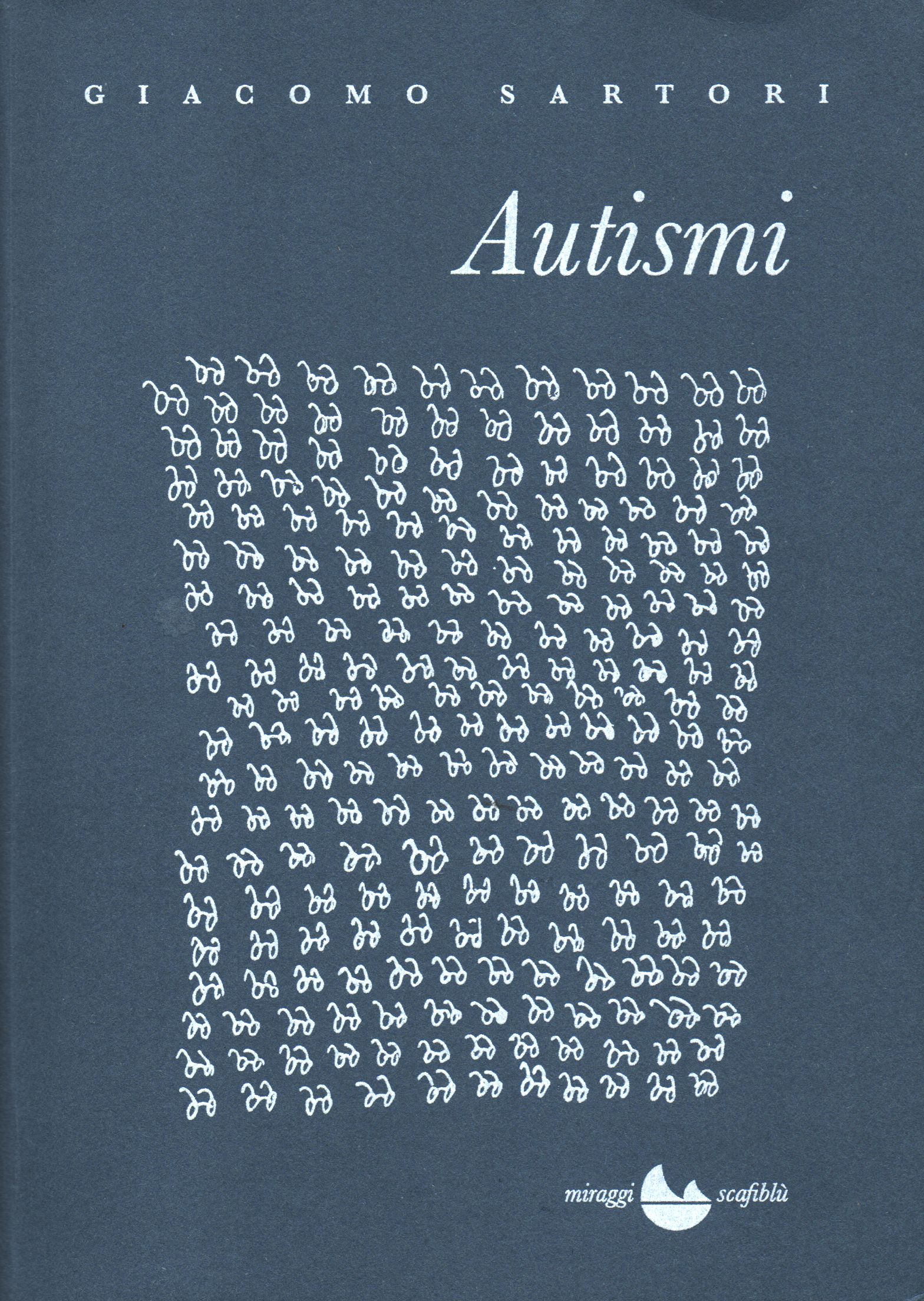

Sempre a firma di Roberto Antolini, su Spiccioli / Letteratura ci sono altre interessanti recensioni di opere di Giacomo Sartori: sui romanzi Rogo, Baco, Io sono Dio, sul successo statunitense di I Am God, sulle poesie di Mater amena e il romanzo Anatomia della battaglia in riferimento alle radici trentine.